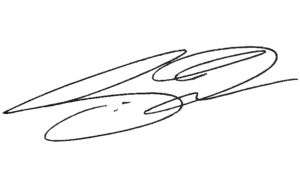La storia ormai la sanno tutti, ma i dettagli in pochi.
Solo chi ha vissuto con me.
I dettagli o i pensieri che avevo.
O i sogni che avevo prima di iniziare quest'avventura, che poi è stata un'avventura.
Da bambino non seguivo la pallacanestro, non ero uno di quelli che ha iniziato perchè si ispirava a qualcuno in particolare.
Andavo a scuola dalle suore, c'era un professore di educazione fisica esterno che ci faceva giocare e mi rendevo conto che mi piaceva.
Non ne uscivo matto, di certo non era un sogno.
Se proprio avessi dovuto scegliere avrei preferito il calcio.
A quei tempi non era come adesso che se non c'è il campo perfetto, in sintetico, le porte fatte per bene o le scarpe di marca i bambini neanche giocano.
Una volta mettevamo due pietre per fare le porte e giocavamo sotto al sole.
Stavamo qualche ora in sala giochi e poi tutto il resto del pomeriggio dietro al pallone.
E quando sentivi le moto Guzzi dei vigili dovevi scappare, altrimenti la palla te la portano proprio via.
Nel calcio sentivo però che mi mancava qualcosa, proprio a livello pratico.
C'ho provato un po' in tutti i ruoli, poco alla volta sono passato dalla difesa fino all'attacco, ma niente.
Non c'era verso.
Per cui verso i 15 anni mi sono dedicato soltanto alla pallacanestro.
A metà della terza media avevo anche deciso di lasciare la scuola.
Mi stufavo e non avevo nessuna voglia di studiare, non mi sentivo portato.
Mio padre lavorava tantissimo.
La mattina passava le ore nella campagna a raccogliere la frutta nei terreni ereditati dal nonno e la sera invece insegnava francese.
Per cui, quando io ho lasciato i banchi di scuola, lui mi ha preso sottobraccio e mi ha detto:
adesso tu lavori con me
Vivevamo in Puglia, nell'entroterra, e lavorare nei campi voleva dire farsi un mazzo così.
Un lavoro duro.
Freddo d'inverno e caldissimo d'estate, sveglie all'alba.
Sacrifici continui.
Mio padre aveva una vera e propria passione per l'agraria, grande almeno quanto quella per lo sport, per cui mi ricordo che andammo anche in Brianza a fare un giro esplorativo.
Lì c'erano molti istituti specializzati e lui ci teneva che almeno uno dei figli prendesse quella strada.
Durante il viaggio lui chiamò in sede dell'allora Clear Cantù ed ottenne di farmi fare un provino: due allenamenti.
Non mi presero.
Quando rientrammo a Ruvo di Puglia ripresi la mia vita di sempre, senza dare troppo peso a quell'episodio.
In fondo ero soltanto un ragazzo timido che era bravo a giocare a pallacanestro.
Bravo sì, ma ce n'erano tanti nelle giovanili più dotati di me.
Eppure in molti, tra loro, non sono riusciti ad emergere.
Avere talento o capacità in un gioco non basta per riuscire ad avere successo, ci sono molti altri fattori in ballo.
Io sono convinto che se uno ha la predisposizione fisica e un pizzico di talento, tutto il resto se lo può creare, come ho fatto io.
A volte mi è venuto da chiedermi: se ce ne sono cento, a livello giovanile, che sono più avanti, perché dovrei riuscire ad arrivare io, che sono partito 10 metri più in dietro?
È una questione mentale.
Questo è quello che mi sono risposto io.
Di rendita non vive nessuno, bisogna sempre trovare il modo di lavorare.
Con costanza, a testa bassa.
E questo vale per tutti, anche per quelli nati fenomeni.
E io non ho mai fatto parte di questa categoria, quella dei Gasol, dei Navarro, dei Diamantidis.
Ho ancora vivo, davanti agli occhi, l'esempio di Messi e di Ronaldinho.
Quando arrivai al Barca il brasiliano era il Pallone d'Oro uscente, collezionava vittorie e riconoscimenti.
L'anno dopo: un disastro, non cavava un ragno dal buco.
E nei corridoi della polisportiva le voci giravano, eccome se giravano: non si allenava mai, mentre invece la Pulce non smetteva un attimo di lavorare.
La diversa longevità dei due è lì per tutti da vedere.
La fortuna mia è stata proprio questa forse: che io sapevo esattamente cosa mi aspettava se non avessi avuto successo nello sport.
Mi sarebbe toccato tornare a spaccarmi la schiena nei campi.
Uno se lo può anche immaginare il dopo, ma è diverso da saperlo.
Chiedersi: cosa può essere la mia vita senza pallacanestro?
Immagini un ufficio magari, ma non lo sai la fatica che comporta, per uno stipendio che ti permette giusto la sussistenza.
Per questo io volevo a tutti i costi arrivare.
Io dovevo arrivare.
E comunque, per farlo, è servita anche una bella dose di fortuna.
Non posso che ritenermi fortunato perché in tutta la mia vita, in tutta la mia carriera, quando mi sono trovato davanti ad un bivio mi è sempre andata bene.
Buona sorte, istinto o per qualche altro motivo.
La mia carriera vera e propria, quella nella pallacanestro di grande livello, è iniziata a Reggio Emilia, quando avevo 18 anni ed il merito è da dividere equamente tra un caro amico di famiglia, Riccardo, e Virginio Bernardi, grande allenatore dell'epoca.
Io ero all'oscuro di tutto, non sarei mai stato in grado di vendermi da solo.
Mi sentivo più scarso degli altri e mi portavo sempre appresso questo profondo senso di inferiorità, quello che mi spingeva a lavorare più del normale.
Il primo anno di Reggio è stato anche quello in cui avrei dovuto fare la leva, ed ero talmente desideroso di trovare a tutti i costi una strada alternativa rispetto a tornare nei campi che avevo fatto domanda per farlo con i carabinieri.
Perché si guadagnavano 800 mila lire che erano molti di più della paga da soldato semplice.
Vi lascio immaginare la reazione dello staff di Reggio Emilia quando mi è arrivata la cartolina con la convocazione durante il mese di gennaio, pochi mesi dopo il mio arrivo lassù.
L'impatto per me è stato duro, ero arrivato su con un braccio rotto, ricordo di un campetto estivo finito male e mi rammento di essermi tolto il gesso prima di partire per paura che vedendomi ingessato loro ci ripensassero.
Tra quello, il livello 100 volte più alto di quello cui ero abituato e la leva che iniziava, nel mio primo anno non ho praticamente mai giocato.
Ora so che nell'estate successiva loro erano intenzionati a metterci una pietra sopra, a non confermarmi, così liberavano un posto in foresteria per qualcun'altro.
Ma mio padre li chiamò, e li richiamò, fino a che non li convinse che dovevo restare, che avrei fatto bene di sicuro.
Insistette al punto che riuscì a convincerli.
Passai gran parte della stagione successiva in una caserma dei Carabinieri, a Firenze, per compiere il mio servizio di leva.
Riuscivo quasi sempre a farmi assegnare i turni notturni o quelli mattutini.
Ogni giorno poi correvo a prendere il treno delle 14 e 07 che dal binario 5 della stazione di Santa Maria Novella mi portava verso Bologna.
Da lì a Reggio.
Mi allenavo.
In serata facevo il percorso inverso.
Ogni santo giorno.
Non sono mancati i momenti difficili, come quando non avevo il permesso firmato e sono scappato nascosto in una macchina pur di non saltare l'allenamento.
O come quando ho sbagliato treno ed invece che il 14.07 per Bologna ho preso il 14.05, diretto per Roma.
Arrivavo in stazione così tirato da non avere neppure il tempo di controllare il tabellone delle partenze.
Questa era la portata dei sacrifici che ero disposto a fare pur di arrivare, per darmi una chance. E lo facevo sempre con il sorriso.
Per tutti gli anni di Reggio Emilia la sensazione di dover scappare da qualcosa non mi ha mai abbandonato. La paura di dover tornare alla vita precedente se non fossi riuscito ad emergere è sempre stata presente al mio fianco.
E se questo forse era normale all'inizio, diventa un po' più difficile da spiegare con il passare degli anni.
Fare parte della roster della serie A, giocare tanto, anche giocare bene, non mi ha mai fatto sentire al sicuro.
Mi sono sempre sentito in dovere di dimostrare ogni giorno, soprattutto a me stesso, che potevo stare a quel livello solo mettendoci una cura maniacale dei dettagli.
Quando ho giocato le mie prime partite in quintetto in A2 per esempio, anche se in campo facevo tutto bene restavo sempre assillato da mille dubbi e bastava una sola partita giocata malino a farmi dire: ecco, visto, lo sapevo!
Questa sensazione forse mi ha spinto a vivere male alcune esperienze, a godermi la quotidianità molto meno di quanto avrei potuto.
Il giorno del mio matrimonio sono stato in Puglia giusto il tempo della cerimonia facendo avanti-indietro in treno il più veloce possibile perché con Reggio eravamo nel bel mezzo dei playoff.
Che poi avrei anche potuto programmarlo dopo, ma a casa mia il matrimonio è una cosa seria, la sala va prenotata un anno prima e nessuno a Reggio si aspettava di essere ancora in campo il 5 maggio.
Ma questa mia voglia di sacrificarmi, questa esigenza, è anche ciò che mi ha permesso di essere sempre pronto ad adeguarmi al livello nuovo.
Non ho mai smesso di crescere e migliorare.
Nei momenti in cui non riuscivo a sentirmi a mio agio, bello comodo dentro il mio ruolo, l'impronta di questo modo di pensare mi ha aiutato moltissimo.
Ed altrettanto ha fatto il supporto di mio padre.
Lui era un malato di sport, di sport in generale.
Mi ha sempre spinto anche se forse gli sarebbe stato più utile avere la mano di un figlio nei campi ad aiutarlo.
Mi diceva sempre una cosa:
devi fare fare le cose che gli altri non vogliono fare perché se ci riesci giocherai sempre.
Una logica semplice, ma vera.
Perché in una squadra non puoi avere 10 tiratori, a tutti piace fare canestro o avere il pallone tra le mani. Ma in campo ce n'è solo uno, lo stesso per tutti e dieci.
Prendo ad esempio i primi giorni a Bologna.
Sempre mi chiedevo: merito da Reggio Emilia di stare nella Fortitudo, con un contratto assurdo?
Perché si era creata un'asta tra Virtus e Fortitudo.
E quindi: creata l'asta, prezzo alle stelle e mi sono trovato nella Fortitudo con a fianco Myers, Fucka, Karnisovas, Mulaomerovic, Jaric.
Prima partita giocata con la F addosso: il derby.
L'ufficio stampa della Virtus aveva già stampato il volantino con la mia faccia e la maglia delle V nere ed invece mi trovai dall'altra parte.
Tutta la partita a marcare Antoine Rigaudeau.
Anche lì però non riuscivo a smettere di guardarmi indietro: dov'ero rispetto a dove ero partito.
E le parole di mio padre mi hanno aiutato di nuovo a trovare il mio spazio.
In quella squadra erano tutti fenomeni in attacco ma nessuno voleva difendere o correre in contropiede e quindi se lo avessi fatto sarei stato in campo di sicuro, anche in mezzo ai fenomeni.
Mi sono messo a lavorare come un matto sul mio tiro piazzato, ci passavo le ore a tirare da fermo, per crearmi una credibilità che avrebbe permesso ai compagni di giocare in un campo allargato e impedito agli avversari di battezzarmi.
Il tiro per me è sempre stato una questione di meccanica.
Io non mi sono mai sentito un tiratore, mai.
Ma piuttosto uno che poteva fare canestro.
Nelle serate giuste potevo fare canestro. Ma perché una giornata fosse "giusta" era necessario che i giorni precedenti fossero stati perfetti.
Che avessi allenato anche il minimo dettaglio, che avessi mangiato rispettando la mia dieta, che sentissi le gambe forti ed esplosive al loro 100%.
Dietro ad ogni tiro preso in campo c'era una costruzione complicata e profondissima, come le fondamenta di una casa di cui riesci a vedere solo il camino in cima.
Costruito quello, con tutta la sua routine e spostato stabilmente nel ruolo di playmaker ho trovato il mio posto per davvero.
Non ero certo un play, ma spostare Myers mica si poteva, e anche Tanjevic in Nazionale mi aveva provato in quel ruolo, anche perché lui era fissato con la taglia, la prestanza fisica e per i palleggiatori avversari ero abbastanza difficile da marcare.
Spiegare cosa fosse per me il tiro e quanto fossero delicati i suoi equilibri è stato molto complicato a volte.
A Barcellona, dove ero andato dopo lo scudetto con la Fortitudo per provare a crescere e salire ancora, non è stato semplice farmi conoscere da coach Ivanovic.
Su Dusko esistono mille leggende: sono tutte vere. Tutte.
Era durissimo, un nazista della pallacanestro.
Allenamenti massacranti, ripetute di allunghi prima della doccia, sedute di atletica fatte all'alba.
Per lui giocava chi restava in piedi, come le corse dei marines americani.
Potevi anche essere più scarso degli altri, ma se resistevi allora lui ti faceva giocare.
Ma tutto questo per me non era un problema, anzi, ero uno molto facile da allenare.
Trovare però l'equilibrio tattico in una squadra così non è stata una passeggiata.
Lui mi vedeva come un tiratore puro, e come tale voleva usarmi, ma io, che tiratore puro non mi ero mai sentito, capitava che passassi qualche tiro ogni tanto.
Soprattutto se non mi sentivo in perfetto equilibrio.
Ricordo che una volta fermò l'allenamento e mi disse:
"non vuoi tirare? Bene, corri!"
E mi mise a bordo campo a correre da solo, su e giù.
Ad oltre trent'anni.
Ma è anche così che non ho smesso di diventare un atleta ed un compagno migliore.
Poi con l'aiuto di Zoran Savic sono riuscito ad inserirmi al meglio, a farmi conoscere ed apprezzare per l'uomo e il giocatore che sono.
Quando hanno mandato via Dusko e preso Pascual, che prima gli faceva da vice, abbiamo iniziato a fare anche grandi risultati.
Perchè Pascual portava in campo il meglio di Dusko, ma con una maggiore attenzione alle dinamiche del gruppo, e con lui abbiamo vinto tanto.
I sei anni trascorsi lì sono stati magnifici, la mia famiglia ha sofferto enormemente quando ce ne siamo dovuti andare: abbiamo pianto tutti.

© THEOWLPOST
È stato forse quello il giorno in cui io ho iniziato a tirare un po' il fiato.
La mia lunga rincorsa era finita, più in alto di lì non si poteva andare ed il ricordo lontano dei campi e della frutta da raccogliere era sparito.
Il mio fisico iniziava a presentare il conto, a mostrare i primi segni del tempo.
Ho giocato ancora.
Prima a Cantù, che avevo a lungo osservato da lontano, perché mi piaceva il basket di Trinchieri e perché, vista da fuori mi allettava l'idea di sfidare l'egemonia di Siena.
Ma in quell'anno ho raccolto meno di quanto avrei voluto, ho iniziato a soffrire di infortuni muscolari, che erano una cosa nuova per me.
Non li conoscevo, e ho finito anche per essere io stesso causa di una ricaduta.
Poi ho avuto modo di toccare con mano lo spogliatoio di Milano, l'anno dopo, quello chiacchierato, quello di cui tutti parlano ed è stato indiscutibilmente il peggior anno della mia carriera.
Che rifarei comunque.
Come rifarei ogni cosa.
E può sembrare una retorica banale, ma è la verità.
È stato difficile a volte.
Avrei voluto essere capace di viverla con maggiore leggerezza magari.
Ma quello non sarei stato io.
Io sono venuto da Ruvo, un paesino dell'entroterra pugliese.
Ho raccolto la frutta per tre anni, la mattina all'alba.
Sono entrato in un settore giovanile importante che ero quasi maggiorenne e che mi preoccupava di più la leva che non il basket.
Io ho lavorato più degli altri, però.
Ho fatto, nelle squadre in cui ho giocato, quello che gli altri non avevano voglia di fare.
Io mi sono costruito un'avventura straordinaria.
Gianluca Basile / Contributor