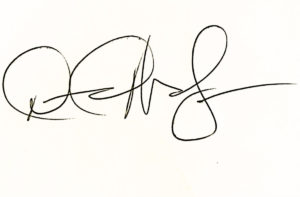È molto difficile per me fermarmi e guardare indietro, non lo faccio quasi mai.
È un modo d'essere che non mi appartiene, quello di dare spazio al ricordo ed alla nostalgia, preferisco restare con le spalle attaccate al muro dell'ora presente e scrutare avanti, in direzione di ciò che deve ancora essere, di quello che posso ancora costruire, visitare o scoprire.
A volte però sento il desiderio di spiegare da dove nascono certi aspetti del mio carattere, alcuni di quei frammenti del mio approccio al gioco e all'esistenza che mi porto appresso nel borsone, in giro per il Mondo.
Credo che sia stato Dio, o è stato l'Universo forse, a tatuarmi sotto la pelle, vicino alla sorgente del mio DNA l'ideogramma della competizione. Lo sento da sempre bruciare dentro come se la cicatrice lasciata dal tatuatore fosse sempre perennemente fresca.
Da piccolino il mio primo amore è stato il football e ricordo sempre che nel quartiere ne giocavamo una versione unica e selvaggia: ognuno per sè stesso, 20 ragazzini ed una palla, punto. Dovevi out-run everybody, andare più veloce di tutti, per segnare, non avevi alternative.
Tutti ad inseguire quello con l'ovale che correva verso la sola end-zone prevista in un campo che avevamo delimitato con le braccia e l'immaginazione.
Un gioco, perchè era ancora un gioco, privo dell'organizzazione dello sport di squadra che mi ha subito esposto ad una grande fisicità, che è qualcosa che mi è rimasto dentro, profondissima. Qualcosa che semplicemente adoro.

© Basket Leonessa Brescia
Non ho mai conosciuto il lato paterno della mia famiglia e le figure più importanti nella mia adolescenza sono state tutte donne. Donne tutte fortissime.
Mia zia Juliette, sapeva fare tante cose diverse, era avvocato e attrice insieme.
Era presente e comprensiva. È stata lei a comprarmi la mia prima tessera d'iscrizione ad una palestra, la YMCA. Ed era sempre lei ad accompagnarmici ogni giorno, o a recuperarmi alla fermata dell'autobus la sera tardi, mi dava modo di pensare solo al gioco, perchè al resto stava già pensando lei.
Il permesso di esser leggeri è un dono pesante, lo riconosco.
Poi c'era nonna, con lei non si facevano certo grandi conversazioni: tante generazioni di differenza, linguaggi forse troppo differenti.
Ma quando due persone sono legate da qualcosa di profondo e sincero che la parola non riesce a rendere dialogo, la comunicazione trova sempre altre vie per esprimersi, per mettersi in piedi e camminare, per cementare quello che io provo per te e quello che tu provi per me.
È come quando nello spogliatoio non trovi il modo di connetterti con un compagno nuovo, e poi quando qualcuno mette, senza saperlo, la canzone giusta vi ritrovate tutti e due a cantarla ridendo, che in fondo non siete poi così diversi.
Con nonna io passavo le ore a guardare lo sport in tv, mi mostrava e mi spiegava le regole del baseball, del tennis, del basket. A casa sua era sempre quello il nostro rituale ed era davvero come se fosse sacro per me, qualcosa a cui non avrei mai rinunciato e che mi ha influenzato moltissimo.
Dove c'ero io c'era lo sport, o forse dove c'era lo sport arrivavo sempre io, non importa, fa poca differenza, è da sempre stata un'unione indissolubile, ciò che più di qualunque altra cosa mi definisce.
Ho cominciato nel dopo scuola, facevamo i compiti e più in fretta li finivi e più a lungo potevi giocare. Ma il gruppo nel quale ho davvero imparato il senso dello sport è sicuramente quello dei ragazzi del mio neighbourhood.
Quella in cui sono cresciuto, a Chicago, non può essere definita una zona facile: è un quartiere duro in cui vivere. Ma da bambino, vivendoci dentro, immerso fino al collo come parte attiva di gruppo di coetanei, io non ci davo troppo peso.
La vita di tutti è fatta di ups and down, la mia non faceva eccezione.
Ci sono stati momenti complicati, che è persino difficile per me richiamare alla mente, eppure sento che la mia, nel complesso è davvero stata un'adolescenza fortunata.
Il mio primo, folle, amore è stato quello consumato con il football, ma io sono nato nel 1983 e l'anno seguente i Bulls scelsero Micheal Jordan al draft: era l'inizio di una grande febbre che avrebbe contagiato tutta la città e sarebbe stata lunga ventanni almeno.
In tutto l'Illinois il basket letteralmente si respirava in quegli anni.
Lo si respirava anche involontariamente quindi, per strada, nei campetti, nelle high school, non ci potevi fare niente. È stato come un onda, uno tsunami che ha travolto intere generazioni, trainate da quella squadra straordinaria, entrata prepotentemente nell'immaginario collettivo di tutti i ragazzini e gli adulti di quel periodo e anche dopo.
Quella era una pallacanestro differente, più cattiva e dura, fatta più da navy seals che non da supereroi come accade oggi. Le squadre erano divisi in reparti speciali,ognuno con le proprie mansioni precise.
In quei Bulls, c'era chi doveva segnare, chi picchiare e portare i blocchi, chi prendere i rimbalzi, chi tirava solo da libero. Ed era quasi sempre libero, ma non per meriti propri.
Poi c'era Scottie Pippen, e lui invece sembrava avere la licenza di fare tutto quello che volesse in campo: rimbalzi, assist, schiacciate. Metteva insieme cifre da vero all around, che sono magari all'ordine del giorno oggi, ma che allora mi lasciavano a bocca aperta. Ai miei occhi la sua completezza era stupefacente: nelle Finals del '91 marcava Magic ed allo stesso tempo era l'attaccante più pericoloso dopo Michael.
È stato, dal punto di vista tecnico, il mio primo role model nel basket.

© Basket Leonessa Brescia
Il basket comunque a me piaceva, non quanto il football ovviamente, ma mi piaceva ed ora posso anche dire quanto io gli sia grato. Lo sono davvero perchè mi ha permesso di trovare una strada piena di sfide e di battaglie da poter correre tutta d'un fiato, una gigantesca bombola d'ossigeno per permettere la sopravvivenza della mia natura competitiva.
Ancora oggi giro il mondo grazie al basket, e anche se non è stato amore a prima vista, posso dire che siamo riusciti a costruirci comunque un solido matrimonio duraturo.
Non mi è comunque stato chiaro fin da subito quanto desiderassi diventare un giocatore professionista.
La cosa più importante per me è sempre stato dar sfogo al mio desiderio di giocare e di essere parte attiva di un gruppo.
Quand'ero ragazzo non non ero certo tra i più dotati della squadra, tutt'altro: ero troppo magro nonostante il football, avevo i piedi lenti e per questo in difesa facevo schifo, non palleggiavo bene e la sola cosa che sapessi fare decentemente era tirare.
Quello e in più ero un combattente, un combattente vero.
Non c'era amichevole, campetto, partita ufficiale o allenamento nel quale io non arrivassi col dito a grattare la superficie dei miei limiti tecnici e fisici pur di stare in campo, anche solo qualche minuto in più.
Credo che sia stato questo ad influenzare più di qualunque altra cosa la mia formazione tecnica: pur di stare in campo, insieme a della gente che sembrava più dotata di me, io ero pronto a fare di tutto. Difendere, prendere rimbalzi, passare la palla, qualunque cosa purchè il coach mi preferisse ad un mio compagno per il prossimo minuto di partita.
Qualunque.
E così ho imparato prima di subito a mettermi a disposizione sul serio, ho imparato che per essere parte di qualcosa che ti piace devi essere disposto a fare anche alcune cose che non ti piacciono.
Ho imparato che per una squadra un giocatore utile a volte vale più di un giocatore forte ed io a volte, magari, sono stato tra i più forti della squadra, ma, senza dubbio, sono sempre stato utile, ci potete scommettere.
Io volevo fare parte della squadra, avere un ruolo riconosciuto dagli altri.
Non importa quale squadra, non importa quale ruolo.
Durante il mio anno da freshmen all'high school giocavo nella squadra B di basket e anche in quella di football, non vedevo un motivo sufficientemente valido per scegliere uno solo. A me interessava giocare.
Ma alla fine della stagione ho deciso di abbandonare il football, primo amore, e per la prima volta in vita mia ho lasciato che fosse l'ambizione a guidarmi. Non più solo il gusto dello stare dentro ad un campo, ma seguire un progetto pratico, reale, per provare a crearmi una carriera professionistica.
L'idea di spingermi il più lontano possibile giocando a basket, a basket e basta.
L'anno successivo ho fatto il sesto uomo di una squadra fortissima che aveva Eddy Curry come uomo simbolo. Lui era the guy e tutti gli schemi e le attenzioni erano per lui, ma intorno al suo talento giocavano altri 7 grandi giocatori ed ognuno di loro era in grado di fare uno step up in qualunque momento, a seconda delle esigenze della squadra e del tipo di avversario.
Quell'anno, finito perdendo la finale nazionale, mi ha fatto capire davvero quanto desiderassi diventare un professionista, mi ricordo ancora l'emozione che ho provato stringendo tra le mani il giornale locale con la mia foto sopra dopo l'ultima partita.
Nella foto piangevo inconsolabile ed è guardando quella che ho sentito un click alla base del cranio: avevo un nuovo scopo e per renderlo tangibile gli insegnamenti ricevuti a Thornwood sono stati fondamentali
Mi hanno insegnato fin da subito a giocare the right way, cercando di riconoscere le situazioni tattiche e non provando ad abbattere il muro a testate sempre e comunque.
Mi hanno insegnato ad avere rispetto per il gioco e per la sua armonia, a difendere per due ed a cercare sempre la giocata corretta, con attenzione e rispetto. Ad andare oltre alle statistiche ed a mettere la giusta attenzione nella creazione dei rapporti con i compagni.

© Basket Leonessa Brescia
Tutto questo è sempre più grande del resto.
Più fondamentale del talento, più importante della chimica tra i giocatori.
Più decisiva delle percentuali al tiro c'è la disponibilità a giocare the right way.
Quando sono arrivato in Europa tutto questo mi ha aiutato moltissimo ad integrarmi in un sistema dove molto spesso l'americano viene accolto con dei pregiudizi ingiustificati, sia da un punto di vista tecnico che umano.
L'americano, per l'occhio dell'europeo, è spesso egoista, menefreghista e se si integra bene nella città oppure no, cambia poco.
Il mio primo anno fuori l'ho trascorso in Polonia e, ad essere sincero, la differenza tra l'approccio americano e quello europeo non l'ho vista in campo, dal punto di vista tecnico, ma soltanto fuori.
É stato un risveglio rude: perchè ho visto come un giocatore polacco venisse per importanza sempre prima rispetto ad uno americano, per il quale si possono mettere a disposizione anche meno attenzioni e affetto che tanto va bene lo stesso.
All'inizio fu uno shock per me, oggi ne rido, perchè ho imparato che ci sono tanti posti invece dove raccogli esattamente quanto semini, e quanto ti meriti, non di meno.
Ho vissuto dentro decine di spogliatoi diversi ed ogni volta, ogni anno, è stato un viaggio emozionante. Ogni stagione è a modo suo indimenticabile, sia che sia una di quelle che sembrano finire in un istante o una di quelle che si trascinano lentamente.
Lo spogliatioio è come una famiglia dove tutto scorre con il tasto avanti-veloce premuto.
È una famiglia perchè, proprio come avviene in una famiglia, i componenti non te li scegli tu, ma devi farteli andar bene comunque, e non bene per così dire, bene sul serio.
Perchè ci devi lottare ogni giorno per i minuti in campo, per l'affermazione personale, ma devi anche essere capace di non dimenticarti il motivo per cui ti pagano: vincere quante più partite possibile tutti insieme.
Lo spogliatoio somiglia ad una famiglia anche perchè a volte non hai voglia di starci, a volte ne hai le scatole piene e vorresti disintossicartene per una sera o due, ma non puoi, perchè quella è casa tua.
E in casa tua devi accettare gli altri per quello che sono, senza distinzioni, mica li puoi cambiare.
Però è anche il posto dove puoi tirare fuori il tuo carattere senza remore, il posto dove i tuoi limiti e le tue paure vengono nascoste dietro le forze degli altri che lo abitano con te.
Ed è così che cerco di costruire il mio ruolo in ogni nuova famiglia con cui inizio una stagione: senza la pretesa d'essere perfetto e con la mente aperta.
Con il desiderio di competere all'interno della squadra con ferocia, perchè è il solo modo di farlo poi anche fuori tutti insieme, oltre ad essere l'unica maniera per rispettare davvero i compagni ed il loro lavoro.
Quando questo accade, ed accade per tutti, allora la squadra ha davanti a sè traguardi importanti.
In tutte le squadre vincenti di cui ho fatto parte è stato questo mind set all'interno dello spogliatoio a rendere possibili certi risultati.
Spogliatoi tutti uguali eppure tutti diversi nello stesso orizzonte.
Tutti diversi quanto sono diversi i caratteri e le vite delle persone che li compongono e tutti uguali quant'è identica la fame che chi li abita ha rispetto ad alcuni, semplici obiettivi.
Tutti parlano di quanto sia importante lo spogliatoio, ma quando finisci in un posto dove la gente si comporta davvero di conseguenza te ne accorgi perchè di quel livello d'attenzione sono impregnati anche i muri, e tutto si muove davvero battendo colpi che hanno un suono solo, come i vogatori.

© Basket Leonessa Brescia
Le squadre vincenti sono così.
Ma attenzione, che le squadre vincenti non sono mica solo quelle che vincono.
Quand'ero più giovane e meno diplomatico ripetevo sempre a me stesso ed agli altri una frase che avevo sentito dire a Kobe, in un'intervista:
una stagione in cui non vinci il titolo è un fallimento!.
Per anni ho creduto che fosse vero.
Soltanto con il tempo, diventando più vecchio, ho imparato a capire che le sconfitte sono soltanto uno dei due frutti che l'albero della competizione di può dare in sorte.
Ho imparato che ci sono delle piccole vittorie anche dentro i momenti più difficili.
Ho imparato che essere un vincente significa più semplicemente non essere un quitter.
Da quando puntavo alla end zone con la palla in mano, sul cemento di Chicago, inseguito da una quindicina di ragazzi, correndo attraverso le cose che non funzionavano, attraverso le mancanze, cercando di godere della gioia del gioco; fino ad oggi non ho mai smesso di essermi fedele.
Questo mi ha insegnato la vita, questo mi ha insegnato la strada:
non ti guardare indietro,
ma sposa una causa,
progetta un piano,
trova per te stesso una maniera di attraversarlo per intero restandoti fedele.
And don't quit.
C'è ancora molto davanti, per te.
David Moss / Contributor