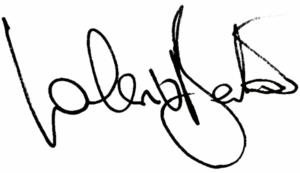Lo spogliatoio era una sauna ma a noi fregava meno di niente.
Stavamo al centro della stanza, abbracciati a formare un cerchio stretto, capace di fare tutt’uno dei componenti della squadra.
Paradenti, tacchetti, fasciature varie, orecchie a cavolfiore. Classico odore di spogliatoio.
Alla mia sinistra invece, sopra due delle panche su cui ci si cambia, trovavano spazio due grosse stampe. Su entrambe c’erano impresse le orme delle nostri mani.
I giocatori prima di te hanno lasciato un segno: quanto è grande quello che lascerai tu?.
Legacy.
Pochi instanti prima di uscire, ancora più stretti, le ultime parole spettavano a me: ero io il capitano di giornata. Si sentiva distintamente il rumore della pioggia che si stava abbattendo fuori ed io, dal mio spicchio di tavola rotonda ho preso la parola, dicendo qualcosa che deve essere suonato più o meno così:
Oggi dobbiamo fare un scelta: o ci accontentiamo di essercela giocata con i più forti d’Europa, andandoci vicino, oppure decidiamo che oggi vicino non è abbastanza, che oggi mettiamo una tacca importante, per noi e per quello che vogliamo fare da qui fino a maggio

Magari con qualche francesismo in più. Ma il concetto era quello.
Non era una finale. Non era neanche una semifinale.
Ma lo sport è molto più di più che le finali e le semifinali. Lo sport è crescita.
Era l’ultima partita di girone di Heineiken Cup, in casa contro gli Ospreys: né noi né loro potevamo più sperare di qualificarci alla seconda fase. Sarebbero andate avanti lo Stade Toulousain e il Leicester, se masticate un po’ di rugby avete intuito che si era trattato di un girone di ferro.
Se invece non lo fate ve lo dico io: tre quarti di nobiltà europea e noi, il Benetton, squadra pluriscudettata in Italia e con una tremenda voglia di farsi rispettare in Europa.
Ora vi starete chiedendo perché io voglia parlare di una partita che non metteva in palio niente o quasi.
Nel rugby le amichevoli non esistono, si chiamano test-match, guai a chiamarle amichevoli. Al massimo esistono amici che vengono a sfidarti, ma nel rettangolo di gioco anche loro smetteranno di comportarsi in maniera amichevole.
Quella partita non avrei dovuto neppure giocarla. Ero in tribuna.
Il capitano, Pavanello, si era infortunato nella Captain’s run, l’equivalente ovale dell’allenamento di rifinitura nel calcio, o del warm up nei mondo dei motori.
Ed io, in poche ore, sono passato da spettatore a capitano.
Questo dettaglio, l’esser capitano, potrà sembrare strano forse, ma è molto più logico di quello che possa sembrare ad una prima occhiata.
Il rugby è, come si dice, uno sport da bifolchi giocato da gentiluomini e il ruolo di capitano ha una valenza unica, quasi cavalleresca; c’è un’etichetta che questi gradi ti impongono e che viene ancora rispettata universalmente.
Solo il capitano parla con l’arbitro.
Solo il capitano.
Ma non è solo questo.
Nel rugby c’è contatto, eccome se c’è, l’adrenalina pompa forte nel cervello come nei muscoli, eppure tutto, in questo sport, può andare a scatafascio in un istante. Non esistono pause dentro la partita.
Non esistono perché se si rompe il funzionamento di anche il più piccolo ingranaggio di una squadra, tutto il giochino si rompe.
Una catena è forte quanto il più debole dei suoi anelli.
Ecco se magari non propriamente un sarto, il capitano è almeno un capo officina che controlla scrupolosamente gli anelli della sua catena.
Leading by example, come dicono gli anglosassoni.
È questo il compito del capitano in una squadra di rugby: condurre dando l’esempio. Viene sempre prima il fare, è condizione non negoziabile.

© Sebastiano Pessina
Torniamo alla partita. Si parte male e ci ritroviamo a meno 12.
Ah a proposito di fare il capitano the right way: non riuscivo a comunicare adeguatamente con l’arbitro e la cosa mi stava andando un po’ sotto pelle.
Non riuscivo proprio ad aprirci un canale costruttivo.
A 3 minuti dalla fine meta per noi e torniamo sotto break.
Ultima azione.
Nel rugby non si fischia finché la palla è viva, quindi in soldoni: hai un ultimo possesso, anche infinito se vuoi, ma se commetti un errore, anche solo gestuale, è finita.
Avanziamo ma perdiamo il pallone, con una pedatona ci rispediscono nei nostri 22. Ergo: 80 metri di campo davanti, zero margine d’errore, maglie così piene di fango da non riconoscere i tuoi compagni.
Grazie al cielo nel rugby i tuoi sono tutti di qua e gli altri tutti di là!
Già lo sapete che abbiamo segnato.
Azione stupenda e lunghissima ed abbiamo segnato.
Si intuisce no? Altrimenti cosa la racconto a fare?
Ma quello che forse nessuno sa, nemmeno tra coloro che hanno visto la meta live dagli spalti, è quanto quel gesto possa essere pesato sul viaggio di quella squadra.
Lo sport è continua ricerca, esplorare i propri limiti fisici, tecnici ed emozionali.
Quando ti guardi indietro vuoi sapere di averli sfidati tutti, oltrepassati in qualche occasione o non sarai pienamente felice di quanto hai ottenuto.
Quella vittoria al fotofinish rappresenta uno dei tanti scogli che un professionista deve superare per crescere. I nostri scogli, in quel periodo si chiamavano Europa, Heineiken, Celtic League, si chiamavano Ospreys.
Quando ho mosso i primi passi nello spogliatoio a Treviso ho subito respirato aria di rugby: organizzazione, struttura, etica di lavoro, cura del dettaglio.
I ragazzi locali erano gli ambasciatori di questi valori. La squadra era profondissima. Dietro le prime linee (nel senso dei titolari non dei piloni) c’era un vero e proprio esercito di ragazzi cresciuti alla Ghirada: lavoratori seri, attenti, capaci di sostenere e di farsi trovare pronti.
Gli allenamenti di Franco Smith poi sono stati una milestone della mia crescita rugbistica: roba tosta. Si intuiva immediatamente il perché quella società collezionasse risultati importanti in Patria e tutto sembrava essere apparecchiato adeguatamente per affrontare il nuovo progetto europeo.
Il progetto era nuovo sul serio, nel senso più ampio del termine, due franchigie italiane avrebbero preso parte alla Celtic League, una sorta di ‘eurolega' composta da franchigie gallesi, scozzesi e irlandesi
Significava competere in un nuovo campionato, lungo, logorante e terribilmente competitivo.
Cambiare lo status della squadra, i suoi obiettivi, la sua sistemazione logistica, i viaggi e molto altro ancora.

Ci sono atleti a cui tutto questo semplicemente non arriva.
Sono animali da competizione, che forse non evolvono mai dallo stadio di bambino-che-insegue-l-ovale, e si riescono a preoccupare soltanto del campo.
Ma quando sei parte di un’organizzazione, di un gruppo e hai consapevolezza delle sue dinamiche ed esigenze allora tutto ha un peso enorme.
Ogni dettaglio conta.
Lo scopo finale, la finish line, meglio ancora la meta è difficile da inquadrare perché di solito va oltre.
Va oltre la titolarità, va oltre la classifica, va oltre i contratti e va oltre i risultati. Ma allo stesso tempo si nutre dei risultati stessi.
Quella vittoria casalinga non ci ha portato nulla in termini di risultato nell’immediato ma è stata un tassello importantissimo per far crescere un gruppo, per alzare il denominatore comune della squadra.
Creare ulteriore consapevolezza, non accettare la sconfitta, sfruttare ogni istante per ottenere sempre il massimo, a prescindere da cosa il massimo sia.
SALTO AVANTI DI POCHI MESI (o indietro di pochi mesi, non ricordo, sinceramente non ha troppa importanza).
Questa è davvero una semifinale.
Il sole splendeva alto sul cielo di Treviso ed io avevo lo stomaco in subbuglio Avevamo sofferto molto durante la stagione contro i nostri avversari di quel giorno e strappare il pass per la finale non sarebbe stato facile.
Fisicamente eravamo inferiori, ma ero convinto che avessimo qualità umane e tecniche sufficienti per portarla a casa. Soffrendo quanto c’era da soffrire magari.
Ma ne ero convinto perché il percorso fatto era stato strabiliante ed ero orgoglioso di aver contribuito alla formazione di quel gruppo, di aver portato il mio mattoncino.
Squadre schierate a centrocampo e cerco con gli occhi di capire come stanno i miei. I nostri e quelli del Prato. Li vedo carichi. Cattivi.
Per quanto cattivi si possa essere a 10 anni.
10 anni. Esatto.
Era la semifinale del Trofeo Topolino, momento esaltante della “carriera” di ogni piccolo rugbista d’Italia, e io, nella veste di allenatore riuscivo ad essere notevolmente più emozionato di tutti i miei ragazzi messi insieme.
Abbiamo vinto, la semifinale ed il torneo. Durante alcuni momenti di quel secondo tempo mi sono ritrovato con gli occhi gonfi di lacrime nascosti strategicamente da cappello e occhiali.
Ero in silenzio, senza parole, ad ammirare una vera prova di maturità, ognuno leader di se stesso e pronto a sostenere il compagno. Una squadra.

© Stefano Delfrate
Erano più piccoli degli altri ma si aiutavano l’un l’altro come a pochissime squadre professioniste ho visto fare in vita mia. Si è trattato senza ombra di dubbio del momento più emozionante che ho vissuto nei tanti anni trascorsi in giro per i prati verdi di tutto il Mondo, senza nulla togliere a quanto ho vissuto con la maglietta da gioco addosso.
E se credete che questo tipo di esperienza non abbia nulla a che fare con una vittoria di una squadra senior in campo internazionale vi state sbagliando di grosso. Sono la stessa identica cosa.
Sono la voglia di condivisione.
La voglia di crescere.
Sono la voglia di lasciare il segno nella mente e nel cuore di una città e di una società prima ancora che nel tabellino dei marcatori.
Io ho sempre vissuto così la mia carriera, con queste linee guida. Non le ho mai perse di vista.
Perché lo sport non è fatto di sole vittorie e sconfitte.
Non è fatto solo delle cose che intercorrono tra una vittoria e una sconfitta.
C’è altro oltre la rivincita.
Lo sport è crescita. Non crescita metaforica eh! Puro e semplice diventare meglio: umanamente, tecnicamente, fisicamente, nel rapporto con gli altri.
Giocare sempre serenamente incazzato, perché vuoi spostare i tuoi limiti più in là dentro al campo ed allo stesso tempo vuoi essere parte di un ingranaggio perfetto fuori, che sia inclusivo. E tutto questo costa fatica, lavoro e tanta attitudine.

Tanti anni fa, più di quanti mi piaccia ammettere, arrivavano le prime convocazioni nelle rappresentative giovanili regionali e nazionali, le prime squadre in cui si inizia a fare sul serio, in cui capisci che devi alzare l’asticella perché quello che fai al club non basta.
Mi ricordo di quando, in quegli anni, giravo per Roma sul mio scooter Honda SH nero, intonando a voce alta l’inno di Mameli mentre superavo le macchine ferme nel traffico e sognavo la maglia azzurra ad occhi aperti.
Nel tragitto per tornare a casa passavo sempre davanti al Flaminio e lo osservavo da fuori con gli occhi di qualunque bambino che adora il rugby. Ero sempre lì dentro quando potevo, anche solo a fare il raccattapalle, come durante la prima storica vittoria italiana nel neonato 6 Nazioni. Desideravo ardentemente arrivare eppure lo desideravo a cuor leggero, con il sorriso.
Ed è così che tutto è arrivato, divertendomi seriamente: “quando se scherza bisogna esse seri” diceva Alberto Sordi nei panni del Marchese Del Grillo.
Ed è così che ho vissuto tutti gli anni trascorsi da professionista, nel costante desiderio di condividere emozioni forti con i compagni, più in generale con le persone, le città e le loro comunità, con i bambini.
Parafrasando Kennedy:
Non chiederti cosa può fare chi ti circonda per te, ma cosa puoi fare tu per chi ti circonda
Ogni gesto conta tantissimo. Butter fly effect.
Ovviamente non sempre tutto gira come vorresti, o come ti sforzi di farlo girare. Ma alla fine il tuo approccio alle cose è ci che ti salva, o che ti affossa. Il 20 maggio 2014 arriva il placcaggio più duro, dall’angolo cieco, quello che non ti aspetti. Sono senza squadra. Come succede in campo ti rialzi subito, l’avversario non deve sapere che ha fatto danni. Dentro, soffri come una bestia. Inesorabile la vita va avanti, non c’è tempo da perdere.
Si tratta solo di riorganizzarsi e di capire come trovare nuovi equilibri, nuove intensità. L’opportunità me l’hanno data le Zebre, grazie alle quali mi sono potuto rimettere in gioco e ripartire.
Ed è stato un viaggio incredibile che mi ha portato fino all’enorme privilegio di rappresentare la mia nazione in una Coppa del Mondo.
Amo il rugby perché mi mette a nudo: a distanza di anni, con le mie personali primavere che avanzano, mi pone sempre delle domande. Come posso migliorare? Cosa posso imparare? Come posso essere utile per i miei compagni ed il mio staff. Le squadre cambiano sempre e sempre lo faranno.
Sono pochi i campioni che sono stati così grandi da restare dentro i libri dei risultati e delle statistiche. I tifosi avranno sempre nuovi idoli e atleti da seguire, ci sarà sempre un giovane emergente che cattura l’occhio del direttore sportivo.
Il nuovo batte il vecchio in quanto a romanticismo, a meno che il vecchio non sia Totti, o Del Piero, o Richie Mc Caw o Diego Dominguez.

Io ricordo sempre la prima maglietta da gioco che ho indossato da bambino, alla Lazio rugby Club.
Era premonitrice. Fronte e retro.
C’era scritto: fare sport senza l’obbligo di diventare campioni. Davanti.
19. Dietro.
Un numero, solo un numero a cui affezionarsi per un bambino.
19, la risata nella smorfia napoletana.
Metafora minimalista di tutta una carriera per una seconda linea nel rugby. Nel rugby “dei grandi” infatti il numero non lo scegli tu ma lo sceglie il coach.
Da 1 a 15 a seconda del ruolo in cui giochi per i titolari.
A crescere dal 16 al 23 per la panchina.
Nel mio ruolo il titolare veste il 5. Chi lo sostituisce il 19.
Numero profetico per essersene innamorati a prima vista.
Ma descrizione perfetta di quanto il rugby mi ha insegnato: disponibilità, voglia di competere, desiderio di andare oltre i miei limiti e certezza di dare un contributo. Sì, certezza. Dare.
Un uomo chiamato a fare lo spazzino dovrebbe spazzare le strade così come Michelangelo dipingeva, o Beethoven componeva, o Shakespeare scriveva poesie. Egli dovrebbe spazzare le strade così bene al punto che tutti gli ospiti del cielo e della terra si fermerebbero per dire che qui ha vissuto un grande spazzino che faceva bene il suo lavoro.
Martin Luther King
Valerio Bernabò / Contributor