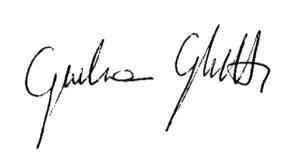Che lo sport sia una palestra di vita lo dicono tutti.
E lo credono in tanti.
Ma sono davvero in pochi quelli che saprebbero anche dire il perché.
Oppure il come avvenga, questo travaso di conoscenza.
In che cosa lo sport ti ha davvero preparato la strada per le cose più importanti della vita. Cosa ti lascia per davvero.
Io sono tra quelli.
Tra quelli che allo sport devono qualcosa sul serio.
Che magari hanno anche un credito da riscuotere, ma che non potranno mai smettere di sentirsi in debito con lui.
Io, fino a quel giorno, ero sempre vissuta in palestra.
Dentro e fuori.
Giorno e notte.
Perché la mamma voleva che la notte dormissi, e quello era il solo modo per stancarmi a sufficienza da farmi addormentare la sera.
Quando mi regalavano le Barbie, io le riciclavo per i compleanni delle mie amiche, perché io preferivo il pallone.
Quando gli altri bambini parlavano dei cartoni animati, io non sapevo mai che cosa dire, perché non li conoscevo, non li guardavo.
Io non avevo tempo per quella roba lì.
Io dovevo giocare.
Correre.
Saltare.
Le mie giornate ruotavano sempre intorno allo sport: ai suoi ritmi, alle sue necessità, alle sue abitudini, che così diventavano anche le mie. Un po’ di ritmica e di un po’ di artistica, e nel mezzo tutto quello che ci passava nella testa, a me e ai miei fratelli, che erano il resto della squadra Ghiretti.

© Photografem
Forse è per questo, che dopo l’operazione, non mi sono data neppure il tempo per piangermi addosso. Un tempo che, volendo, avrei avuto.
Un tempo che forse avrei persino adesso.
Per questo non ho passato nemmeno un minuto a chiedermi cosa mi sarei persa, stando su una sedia a rotelle.
Per questo il mio cervello ha iniziato subito a cercare di capire cosa c’era di nuovo da imparare, data la sua, e la nostra, nuova condizione.
Quale esercizio, quale abilità, quale trucco, come se non fosse mai uscito dalla palestra. Come se non avesse mai smesso di migliorare se stesso.
Undici ore di sala operatoria, dalle 11 della sera alle 6 del mattino, del giorno stesso dell’incidente. Senza il tempo di capire, di realizzare.
Di metabolizzare.
Di quello che è successo, io ricordo tutto, in maniera molto metodica, puntuale.
Ordinata, come sono io.
Era il 4 gennaio del 2010, avevo ancora 15 anni, ma il mese dopo ne avrei compiuti 16, e quello era il primo allenamento dopo le vacanze di Natale.
Il trampolino mi era piaciuto fin dal primo giorno: in fondo chi non ha provato almeno una volta a saltarci sopra, magari in una fiera di paese, per vedere l’effetto che fa essere proiettati su, verso l’alto, verso il cielo.
Qualche anno prima ci eravamo spostati appena fuori Parma, e nella palestra nuova la classe di ritmica non c’era, quindi ripiegai sulla ginnastica artistica.
E fu proprio lì che incontrai il trampolino.
Avevo 8 anni quando ho cominciato.
“Hai il fisico adatto, vuoi provare?”: convincermi, all’epoca, non era poi tanto difficile.

© Photografem
In pochissimo tempo ero arrivata a padroneggiare i fondamentali.
In pochissimo tempo ero arrivata a vincere i Campionati Italiani.
In pochissimo tempo ho iniziato a sentirmi la persona giusta al posto giusto.
Eravamo in pochi a praticare la disciplina, questo lo so, ma non mi interessava, non mi davo neppure il tempo di pensarci, di chiedermi cosa comportasse.
Mi piaceva, altro non serviva.
A 15 anni facevo già acrobazie complesse.
Facevo anche i doppi.
Ma dopo giorni passati lontano dal trampolino, quel 4 gennaio lo dedicammo a riprendere confidenza con il gesto, con le cose più semplici.
Indietro, avanti.
Doppio giro.
All’improvviso sono per aria, perdo la cognizione del tempo e dello spazio, come quando dormi e cadi nel sonno.
Non so più dove sono, quanto sono distante da terra, la posizione del mio corpo.
É questione di attimi, non hai neppure modo di pensare.
Sono automatismi, è tutto automatico, e quando qualcosa va storto lo fa alla stessa maniera: senza fronzoli, senza fanfare, senza spettacolarità.

© Photografem
Sbatto la schiena, le gambe si inarcano e restano lì piegate, come se fossero di marmo, mentre io, ormai a pancia in giù, non riesco più a muovermi.
Chiamo aiuto.
Vengo immobilizzata e messa su un’ambulanza, e di quel viaggio in ospedale ricordo ogni singolo tombino, perché i colpi mi fanno sussultare.
Il dolore lo ricordo lì, solo in quel momento.
Per il resto, solo paura.
Non so se il mio cervello ha deciso di eliminare certi ricordi, o se i ricordi non ci sono perché non ci sono mai stati, non sono mai esistiti.
Non so se il dolore e la paura hanno convissuto, o si sono combattute a vicenda, fatto sta che io, “male”, l’ho sentito quasi solo in ambulanza.
“Ti operano o subito o domani” mi dice l’anestesista, ma ormai io non sento più nulla: la mia sola preoccupazione è “capire”. Io voglio capire.
Cosa puoi capire di una lesione midollare a 16 anni?
Cosa puoi capirne a 30?
Per 15 giorni, dopo l’operazione, ho avuto la sensazione di avere le gambe piegate, perché erano così l’ultima volte che le ho sentite, solo che il cervello non si era ancora abituato alla nuova realtà.
Chiedo alla mamma di fare una foto alla cicatrice, perché è sulla schiena e da sola non riesco a vederla.
Faccio dieci giorni di morfina, che sono l’inizio di oltre sei mesi di ospedale.
Eppure non ricordo disperazione.
Non ricordo sconforto e non ricordo dolore.
Certo, mettere il busto non è esattamente un procedimento piacevole, ma non era su quello che la mia mente si focalizzava.
Ne ricordo però tutti i passaggi: quelle cose che avevo sempre dato per scontato e che dovevo di nuovo insegnare a me stessa. Ma in modo diverso.
Come stare seduta dritta, come vestirmi, la gestione sfinterica.
E lì è arrivato lo sport.
O meglio lì io l’ho ritrovato, perché lui non se n'era mai andato.
Era lì, con tutto il suo spirito pratico, con la sua attitudine all’insegnamento, al concentrarsi sui dettagli, e non sul grande progetto.
Il modello dello sport era già dentro di me, ad un livello inconscio, frutto di anni di palestra, di anni di gioco.
Come se fosse soltanto una nuova acrobazia da imparare, un nuovo obiettivo da raggiungere. Come se le condizioni di partenza non significassero nulla.
Erano un semplice dato.
Una disciplina nuova.
Ho vissuto le mie frustrazioni, come tutti, ma non sono state mai legate all’incidente. Neppure una volta.
Scleri, giornate no, capitano, ma capitano come a qualsiasi altro atleta del mondo.
So che quello che mi è successo è grave, ed è grande.
So che fa alzare il sopracciglio alla gente.
E so anche che è importante che io ne parli, che aiuti la gente a capirlo, a normalizzarlo.
Ma nel profondo io so che non è questa “la mia storia”, che non è questo ciò che mi definisce. Né il dolore, né la sofferenza, né la resilienza o la voglia di non mollare.
Ciò che mi definisce è lo sport, che sia ginnastica oppure nuoto, che sia Olimpiade o oratorio, che sia seduta o in piedi. É stata, è, e per sempre sarà la palestra della mia vita.
Giulia Ghiretti / Contributor